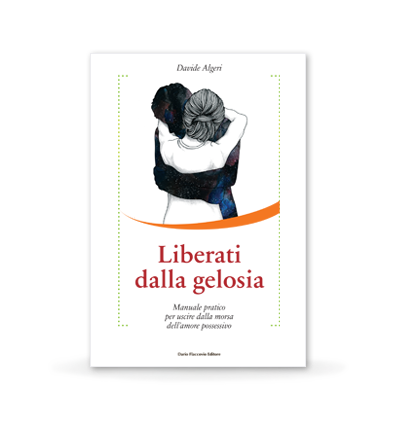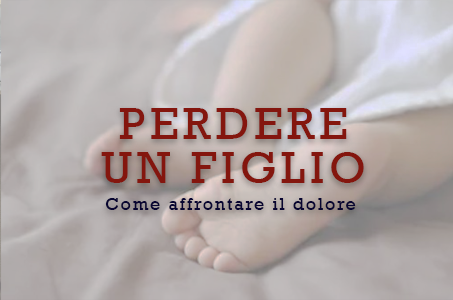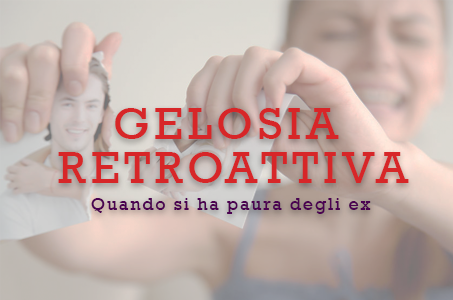
Gelosia retroattiva: quando si ha paura di valere meno degli ex
23 Ottobre 2019
Essere amanti: ridurre i danni quando ci si innamora di un altro/a
3 Novembre 2019“Il trauma è una rottura dell’esperienza quotidiana e della memoria,
un evento non rappresentabile nella nostra mente,
la quale per natura ha bisogno di incasellare i fatti nell’universo dei significati umani.
Questa ferita psicologia si presenta come stordimento ed amputazione delle emozioni
e la sua concretezza perdura nel tempo, provocando sofferenze mentali destabilizzanti.”
(Massimo Ammaniti, 1999)
Trauma: ne avete mai sentito parlare?
Quasi sicuramente avete sentito nominare, almeno una volta nella vostra vita, la parola trauma. Anche in modo arbitrario o comunque non in contesti specifici: quante volte ci capita di sentir dire “è stato un trauma” oppure “ho subito un trauma” anche per situazioni “banali”?
Questo perché ormai il concetto di trauma è entrato nel senso comune e nel nostro linguaggio anche se, spesso, non si è totalmente consapevoli di ciò che realmente esso rappresenti.
Quando parliamo di trauma, quindi, i dubbi e le incertezze non mancano di certo, anche perché c’è un’enorme confusione riguardo questo concetto.
Per esempio, il concetto di trauma spesso è utilizzato per indicare un evento traumatico stressante che include l’esperienza dell’individuo durante l’esposizione all’evento o una risposta dell’individuo subito dopo l’esperienza, nelle settimane, mesi o anni successivi. Spesso, inoltre, il concetto di trauma è utilizzato per indicare sia un trauma psicologico che fisico; oppure ci si può riferire all’evento che ha causato il trauma stesso.
Quel che è certo è che si tratta di un’esperienza totalmente soggettiva (ciò che per un soggetto può essere traumatico, può non esserlo per un altro) che un individuo vive e prova e che può aver effetti negativi: ciò che può sembrar banale o di poca importanza per una persona, può non esserlo per un’altra e può davvero causare danni indesiderati.
Proprio per questo forte impatto che ha sul soggetto, il trauma è spesso oggetto di studi in diversi ambiti come la Psicologia o la Psichiatria.
Ciò che affascina è, appunto, la reazione ad un evento totalmente soggettiva, che può determinare grandi effetti.
In questo articolo parleremo proprio del trauma per cercare di capire cosa è, cosa causa e come poterlo affrontare in modo efficace, per evitare effetti negativi a lungo termine.
Indice dei contenuti
Trauma: cos’è?

In psicologia i primi a parlare di trauma sono stati Janet e Charcot, due filosofi e psichiatri francesi.
Secondo il primo autore il trauma psicologico è un evento che ha caratteristiche potenzialmente rischiose e che proprio per queste caratteristiche risulta “non integrabile” nel sistema psichico della persona. Per questo motivo è in grado di minacciare e di frammentare la coesione mentale del soggetto, creando una dissociazione nel soggetto.
Tale dissociazione genera un processo di dis-integrazione, dove la mente perde la propria capacità di integrare alcune funzioni mentali superiori: sembra essere presente un’assenza di connessione nel pensiero, nella memoria e nel senso di identità della persona.
Charcot, invece, formulò il concetto di “Isteria traumatica” che, secondo l’autore, è causata da un forte shock psichico che risulta essere in grado di causare paralisi isteriche post-traumatiche.
Egli partì da un’evidenza: la paralisi corporea non è sempre dovuta a lesioni organiche, ma può verificarsi anche in assenza di un trauma organico.
Grazie a questi due autori, in psicologia dunque si è iniziato a parlare di trauma, che altro non è che “un’esperienza minacciosa estrema, insostenibile, inevitabile, di fronte alla quale un individuo è impotente.” (Hermann, 1992b; Krystal, 1988; Ven der Kolk, 1996)
Come già affermato da Janet e Charcot, il trauma è quindi un evento insostenibile per il soggetto, poiché ha una miriade di effetti su di esso.
Due tipologie di trauma
Secondo Terr il trauma può assumere due forme essenziali.
Egli, infatti, nel 1991 ha parlato di:
- Trauma di Tipo I: sono episodi singoli che hanno un grosso impatto sul soggetto; sono episodi improvvisi e inaspettati come un incidente, un disastro naturale, un singolo episodio di abuso;
- Trauma di Tipo II: è un trauma costituito da traumi ripetuti o complessi come un abuso reiterato, una violenza domestica, una violenza di comunità o la guerra.
Il secondo tipo di trauma ha maggior impatto sul soggetto, poiché implica il tradimento della fiducia in una relazione primaria, in quanto è perpetrato da qualcuno noto o vicino alla vittima.
Effetti del trauma
Come affermato anche in precedenza, l’impatto del trauma psicologico è totalmente soggettivo e dipende da diversi fattori come:
- le caratteristiche di personalità
- le caratteristiche dell’ambiente circostante
- la struttura emotiva e cognitiva della persona.
Tutto ciò determina un diverso impatto del trauma sul soggetto: un evento non avrà gli stessi effetti su tutti i soggetti.
Per esempio, un incidente d’auto, per alcuni può essere davvero impattante ed avere effetti duraturi, mentre per altri può essere facilmente rielaborabile.
Il trauma, però, non è soltanto tutto ciò che include esperienze estreme o vere e proprie catastrofi, come un incidente o un terremoto, ma può anche riguardare esperienze di trascuratezza o mancanza di rispetto e accudimento che influiscono sull’individuo, sulla sua sicurezza e autostima e sul suo senso di efficacia personale.
Per esempio, essere derisi a scuola e subire bullismo può essere un trauma per un bambino e avere effetti duraturi e deleteri con ripercussioni evidenti sull’età adulta.
Risposte fisiche
La risposta ad un trauma è corporea, ma anche emotiva, perché il trauma è percepito come un pericolo a cui l’individuo sente di dover dare una risposta.
Ecco alcune delle risposte che il soggetto mette in atto.
Attacco o fuga (fight or flight)
Una delle riposte che l’individuo mette in atto di fronte al pericolo è quella dell’attivazione del sistema di attacco o fuga.
Questo sistema è costituito da una serie di reazioni che coinvolgono il corpo e la mente e che determinano uno stato di allerta, attenzione, emozione e percezione.
Queste modifiche a loro volta producono un’azione, che può essere, appunto:
- Attacco che determina un avvicinamento del soggetto al pericolo;
- Fuga che determina un allontanamento dal pericolo.
Freezing (congelamento)
Molte volte il soggetto non riesce a mettere in atto una risposta immediata all’evento percepito traumatico e può capitare che si senta impotente o impossibilitato nel fare ogni tipo di azione.
In questo caso parliamo, appunto, di Freezing, una risposta messa in atto dal nostro corpo per tutelarci dal dolore e dallo shock: il nostro sistema psichico e fisico entra infatti in uno stato di ipoattività temporanea.
Queste sono le risposte immediate del soggetto al trauma, che si manifestano durante o subito dopo il trauma.
Conseguenze psicologiche ed emotive

Dal punto di vista emotivo, le emozioni collegate ed associate al trauma si svuotano di significato e vengono vissute come scollegate dagli eventi che le hanno prodotte.
Il soggetto le vive al di fuori dell’esperienza ordinaria e totalmente ingestibili: ecco perché cerca di evitarle in qualsiasi modo.
Dal punto di vista corporeo, il trauma può produrre una vera e propria sovraeccitazione che si esprime in uno stato di allerta permanente.
Questo fa sì che il soggetto che “entra” in questa condizione sia sensibile a qualsiasi altra forma di allarme.
Dal punto di vista cognitivo, i ricordi del trauma possono restare attivi e intrusivi determinando un’interruzione della vita quotidiana della persona. Questo perché è come se l’evento non fosse del tutto trascorso, ma si ripresentasse di continuo, attraverso flashback e incubi ricorrenti, caratterizzati dal fatto di essere particolarmente reali e quindi sconvolgono la mente del soggetto.
Spesso, si può poter presentare un senso di colpa ricorrente: ci si rimprovera, spesso, per non essere stati attenti o per non aver evitato alcune situazioni.
Diversi esiti post-traumatici
Dopo aver vissuto un trauma, si possono avere diversi esiti e tutto ciò dipende da come il soggetto elabora tale esperienza e, quindi, dalle sue caratteristiche personali. Gli esiti più comuni, che rappresentano dei veri e propri disturbi, sono inseriti del DSM-5.
Tra questi abbiamo il Disturbo Acuto da Stress e il Disturbo Post-Traumatico da Stress.
Disturbo Acuto da Stress
Si parla di Disturbo Acuto da Stress quando è presente una sintomatologia a seguito dall’esposizione del trauma o, in altri casi, dopo essere venuto a conoscenza di traumi o esperienze negative vissute da persone care o a cui si è assistito in prima persona.
In questo caso si ha una risposta acuta: la durata dei sintomi interessa un periodo di tempo che va da 3 giorni a 1 mese, successivamente l’esposizione al trauma.
I sintomi che il soggetto può presentare sono di diversa natura e possono essere classificati in cinque categorie fondamentali (APA, 2013):
- Sintomi d’intrusione: con tali sintomi ci riferiamo a vere e proprie intrusioni cognitive che si manifestano con improvvisi e ricorrenti flashback, ricordi intrusivi e sogni il cui contenuto e le emozioni suscitate sono riconducibili all’esperienza traumatica.
Inoltre può verificarsi una marcata e amplificata risposta di stress a stimoli interni o ambientali che ricordano o sono associati al trauma. - Umore negativo: facciamo riferimento ad un tono dell’umore perlopiù negativo dove le emozioni dominanti sono quelle di paura, tristezza, rabbia o vergogna.
- Sintomi dissociativi: facciamo riferimento all’alterato senso di realtà che può riguardare la percezione di sé stessi (nota come depersonalizzazione) o dell’ambiente circostante (nota come derealizzazione); inoltre è presente l’incapacità di ricordare elementi dell’evento traumatico (detta amnesia dissociativa).
- Sintomi di evitamento: qui facciamo riferimento ai diversi tentativi di evitamento di ricordi spiacevoli, pensieri ed emozioni relativi all’evento traumatico o degli stimoli esterni che innescano i ricordi, i pensieri o i sentimenti negativi associati all’evento.
Il soggetto può fare ricorso all’automedicazione tramite alcool e droghe quando sente una sopraffazione di ricordi o emozioni legati al trauma. - Sintomi di attivazione fisiologica (arousal): facciamo riferimento a tutti i disturbi dettati da un’iperattivazione, come i disturbi del sonno, comportamento irritabile ed esplosioni di rabbia improvvisa, anche in assenza di provocazione, sintomi di ipervigilanza, aumentata sensibilità alle potenziali minacce o particolare reattività di fronte a stimoli inattesi. Rientrano in questa categoria anche i problemi di concentrazione come la difficoltà a ricordare particolari della vita quotidiana o nel mantenere l’attenzione su un compito per un periodo prolungato.
Disturbo post traumatico da Stress
“Quando non è possibile resistere né fuggire, il sistema umano di auto-difesa viene sopraffatto e si disorganizza.
Ogni aspetto della normale risposta al pericolo, avendo perso la sua utilità,
tende a permanere in una modalità alterata ed amplificata
per molto tempo dopo che l’effettiva situazione di pericolo è terminata”
(Judith Herman, 1992)
Molto noto in psicologia, ma anche nel senso comune è proprio il Disturbo Post traumatico da Stress.
Negli Stati Uniti, come riporta il DSM, tale disturbo colpisce il 5% degli uomini e il 10% delle donne e può manifestarsi a qualunque età, sebbene i bambini e gli anziani siano più vulnerabili (APA, 2013).
I risultati dell’European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD), studio condotto su iniziativa dell’OMS in diversi paesi europei, tra cui anche l’Italia, hanno mostrato che più della metà della popolazione italiana (56,1%) è stata esposta ad almeno un evento traumatico, con un rischio di sviluppare un Disturbo Post traumatico da Stress che va dal 12,2% per gli eventi legati alla guerra allo 0,8% per la violenza sessuale (Carmassi, Dell’Osso et al., 2014).
Ma cos’è il Disturbo Post traumatico da Stress?
Si tratta di una risposta cronica che determina la presenza di una sintomatologia per un tempo prolungato che vada oltre il primo mese dopo essere stato esposti ad un trauma. La risposta è cronica anche perché si ha la compromissione della vita del soggetto in diversi ambiti, da quello lavorativo a quello personale.
Anche in questo disturbo si ha la presenza delle cinque categorie di sintomi descritte precedentemente: ciò che lo differenzia dal Disturbo Acuto da Stress è proprio la presenza dei sintomi per un tempo prolungato.
Resilienza
Ma le persona, non sviluppa soltanto risposte disturbanti. Il trauma può essere rielaborato e, quindi, superato, grazie alla propria resilienza, la quale rappresenta proprio un percorso post-traumatico più favorevole, in cui si evidenzia una tendenza a mantenere un equilibrio stabile nel funzionamento, nonostante possibili malesseri e sintomi temporanei.
Questa risposta è: “simile a quella messa in atto fisicamente da parte del sistema immunitario quando il corpo combatte e sconfigge un attacco infettivo.” (Oliviero Ferrari A., 2003).
Come affrontare efficacemente il trauma?
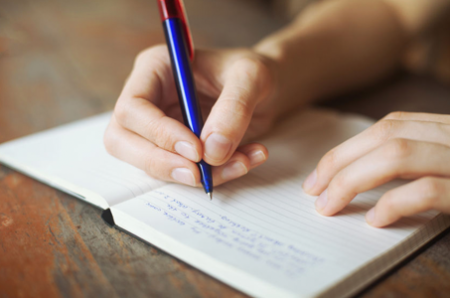
Come abbiamo detto, tutto dipende dalle nostre caratteristiche personali, ma anche da come lo affrontiamo.
Quindi a questo punto una domanda sorge spontanea: come fare per affrontarlo al meglio.
Vediamo alcune utili strategie.
- Muoviti! Questa potrà sembrare una strategia inutile o comunque poco risolutiva perché, molte volte, il trauma è maggiormente associato alla sfera psichica che a quella fisica. Ma come abbiamo visto anche il corpo subisce degli effetti (stati di iper-attivazione o di paura), a causa del trauma.
In tal senso l’esercizio e il movimento aiutano a bruciare l’adrenalina in circolo, riducendo molti dei sintomi legati al trauma. Molto efficace è l’esercizio ritmico che coinvolge entrambi gli arti. - Accetta i vissuti emotivi. È normale che il trauma attivi determinate risposte comportamentali, come è normale che attivi anche risposte emotive, come rabbia, tristezza, paura o senso di colpa. Diventa fondamentale accettarle tutte, poiché rappresentano una risposta normale del corpo ad un evento anormale.
- Datti il tempo di guarire. Qualunque sia l’esperienza vissuta, non cercare di forzare a tutti i costi il processo di guarigione e, soprattutto, autorizzati a provare ciò che senti, senza giudizi o sensi di colpa.
- Vai oltre il senso d’impotenza. Molte volte, di fronte ad un trauma, possiamo sentirci impotenti: questo perché l’evento che viviamo può metterci a dura prova, superando le nostre capacità di reazione. Ma siamo davvero impotenti? No! Ricorda che noi tutti abbiamo punti di forza e abilità di coping che possono aiutarci a superare i momenti difficili. Sicuramente ciò che hai vissuto ti ha messo in crisi, ma puoi essere forte e se vuoi, sei in grado di superare tutto. Devi soltanto credere nelle tue abilità.
Riprendi quindi le tue attività quotidiane e ciò che ti fa sentire sicuro/a e potente! - Racconta per iscritto ciò che hai vissuto. Scrivere è un potente mezzo utile per rielaborare il proprio trauma e il proprio vissuto. La scrittura può infatti servire a processare meglio le emozioni che vivi (Approfondisci come elaborare il dolore attraverso la scrittura). Questo perché comunica indirettamente alla mente che ci stiamo prendendo cura della situazione.
Scrivere del trauma, oltre ad attraversare il dolore, che spesso si tende ad evitare in questi casi, aiuta a ricostruire a livello cognitivo, quanto accaduto, fornendo un senso e un ordine temporale. Questo processo aiuta a collocare il passato nel passato, evitando che questo torni nel presente a disturbarci (Milanese, e Cagnoni, 2009).
Prova a mettere in pratica questi suggerimenti concreti e sentirai pian piano il trauma meno presente!
Riferimenti
- American Psychiatric Association. (2013). Manuale diagnostico e statistic dei disturbi mentali (5a Ed.): DSM-5. Trad. it. Raffaello Cortina, Milano 2014.
- Atwoli, L., Stein, D. J., Koenen, K. C., & McLaughlin, K. A. (2015). Epidemiology of posttraumatic stress disorder: prevalence, correlates and consequences. Current opinion in psychiatry, 28(4), 307.
- Bernstein, E. M., Putnam F. W. (1986). Development, reliability, and validity of a dissociation scale. Journal of Nervous and Mental Disease, 174(12), pp. 727-735.
- Brewin, C. R., Cloitre, M., Hyland, P., Shevlin, M., Maercker, A., Bryant, R. A., … & Somasundaram, D. (2017). A review of current evidence regarding the ICD-11 proposals for diagnosing PTSD and complex PTSD. Clinical Psychology Review, 58, 1-15.
- Brown R.J. (2006). Different types of “dissociation” have different psychological mechanisms. J Trauma Dissociation. 2006;7(4):7-28.
- Bryant, R. A. (2018). The Current Evidence for Acute Stress Disorder. Current psychiatry reports, 20(12), 111.
- Carmassi, C., Dell’Osso, L., Manni, C., Candini, V., Dagani, J., Iozzino, L., … & De Girolamo, G. (2014). Frequency of trauma exposure and post-traumatic stress disorder in Italy: analysis from the World Mental Health Survey Initiative. Journal of psychiatric research, 59, 77-84.
- Costello, E. J., Erkanli, A., Fairbank, J. A., & Angold, A. (2002). The prevalence of potentially traumatic events in childhood and adolescence. Journal of Traumatic Stress: Official Publication of The International Society for Traumatic Stress Studies, 15(2), 99-112.
- Courtois, C.A. & Ford, J.D. (2009). Treating complex traumatic stress disorders. The Guilford Press
- Darves‐Bornoz, J. M., Alonso, J., de Girolamo, G., Graaf, R. D., Haro, J. M., Kovess‐Masfety, V., … & Gasquet, I. (2008). Main traumatic events in Europe: PTSD in the European study of the epidemiology of mental disorders survey. Journal of traumatic stress, 21(5), 455-462.
- Dutra L., Bureau J. F., Holmes B., Lyubchik A. & Lyons-Ruth K. (2009), Quality of early care and childhood trauma: A prospective study of developmental pathway to dissociation. Journal of Nervous and Mental Diseases, 197, 6, pp. 383-390.
- Farina, B., Liotti, G. (2011). Dimensione dissociativa e trauma dello sviluppo. Cognitivismo Clinico, 8, 1, 3-17
- Giusti E., Montanari C., 2000, Il disturbo post-traumatico da stress. In Trattamenti Psicologici in emergenza, Sovera Multimedia, Roma.
- Herman, J. L, Guarire dal trauma, Roma, ed. scientifiche Ma.Gi. srl, 2005.
- Holmes EA, Brown RJ, Mansell W, Fearon RP, Hunter EC, Frasquilho F, Oakley DA. (2005) Are there two qualitatively distinct forms of dissociation? A review and some clinical implications. Clin Psychol Rev. 2005 Jan;25(1):1-23
- Horowitz M.J., 1986, Stress Response Syndrome: a review of post-traumatic and adjustment disorders. In Hospital and community Psychiatry, 37, 241-249.
- Howlett, J. R., & Stein, M. B. (2016). Prevention of trauma and stressor-related disorders: a review. Neuropsychopharmacology, 41(1), 357.
- Linley P.A., Joseph S., 2004, Positive change following trauma and adversity: a review. In Journal of Traumatic Stress, 17, 11-21.
- Milanese, R., Cagnoni, F. (2009). Cambiare il passato: Superare le esperienze traumatiche con la terapia strategica. Ponte alle Grazie. Firenze.
- Oliviero Ferraris A., 2003, Resilienti: la forza è con loro. In Psicologia Contemporanea, 179, 18-25.
- Perry S., Difende J., Musnigi G. et al., 1992, Predictors of post-traumatic stress disorder after burn injury. In American Journal of Psychiatry, 149, 931-935.
- Pietrantoni L., Prati G., 2006, Oltre la tempesta: il lato nascosto del trauma. In Psicologia Contemporanea, 198, 40-48.
- Rosner, R., König, H. H., Neuner, F., Schmidt, U., & Steil, R. (2014). Developmentally adapted cognitive processing therapy for adolescents and young adults with PTSD symptoms after physical and sexual abuse: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 15(1), 195.
- Tagliavini, G. (2011). Modulazione dell’arousal, memoria procedurale ed elaborazione del trauma: il contributo clinico del modello polivagale e della psicoterapia sensomotoria. Cognitivismo Clinico, 8 (1), 60-72.
- Thompson, R. W., Arnkoff, D. B., & Glass, C. R. (2011). Conceptualizing Mindfulness and Acceptance as Components of Psychological Resilience to Trauma. Trauma, Violence, & Abuse, 12(4), 220–235.
- Van der Hart, O., Nijenhuis, E.R.S., Steel, K. (2006). Fantasmi nel sé. Trauma e trattamento della dissociazione strutturale. Milano: Cortina, 2011
Per fissare un primo appuntamento puoi scrivermi un'e-mail all'indirizzo davide.algeri@gmail.com
o contattarmi al numero +39 348 53 08 559.
Se ti è piaciuto questo articolo puoi seguirmi sul mio account personale di Instagram, sulla Pagina Ufficiale Facebook di Psicologia Pratica o nel Gruppo di Psicologia Pratica. © Copyright www.davidealgeri.com. Tutti i diritti riservati. È vietata la copia e la pubblicazione, anche parziale, del materiale su altri siti internet e/o su qualunque altro mezzo se non a fronte di esplicita autorizzazione concessa da Davide Algeri e con citazione esplicita della fonte (www.davidealgeri.com). È consentita la riproduzione solo parziale su forum, pagine o blog solo se accompagnata da link all’originale della fonte. È altresì vietato utilizzare i materiali presenti nel sito per scopi commerciali di qualunque tipo. Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive modifiche.
Richiedi un primo contatto