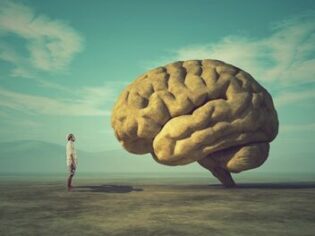
La persona razionale
16 Ottobre 2022
La persona empatica
30 Ottobre 2022 La vergogna è un’emozione secondaria, ovvero non è presente sin dalla nascita; può avere una valenza negativa e sembra essere legata all’ambiente in cui cresciamo e viviamo.
La vergogna è un’emozione secondaria, ovvero non è presente sin dalla nascita; può avere una valenza negativa e sembra essere legata all’ambiente in cui cresciamo e viviamo.
Quando si parla di vergogna non sempre si è consapevoli dell’importanza che questa emozione ricopre nella nostra vita di chi la sperimenta.
Cos’è la vergogna?
La vergogna è uno “stato affettivo negativo che si verifica in risposta a una trasgressione o mancanza, è un’emozione autocosciente, il che significa che l’autoriflessione è fondamentale per il suo verificarsi” (Tignor & Colvin, 2017).
Da questa prima definizione sembra chiaro che la vergogna è un sentimento di imbarazzo che nasce quando percepiamo di aver fatto qualcosa di immorale.
In tal senso la vergogna gioca un ruolo fondamentale per la nostra sopravvivenza, in quanto, senza di essa, come potremmo pensare di aderire alle leggi, alle norme culturali e di comportarci in modo sano?
La sua manifestazione può creare un forte disagio fino a compromettere il benessere psicologico di chi la manifesta. Questo perché, insieme a questa si possono sperimentare altre paure come quella di essere giudicati o disprezzati.
La funzione della vergogna
Da qui la funzione della vergogna è principalmente sociale in quanto rappresenta quasi un sistema normativo interiore che scoraggia la violazione delle norme sociali e morali.
In tal senso la vergogna rappresenta uno strumento evolutivo. È un’emozione sociale che ha lo scopo di impedire di agire solo per il puro interesse personale.
Questo finché non diviene dannosa: in tal caso può perdere questa sua efficacia e diventare in alcuni casi problematica e disadattiva.
Questo quando si traduce in una svalutazione di sé e quando ci porta a pensare di essere inutili, cattivi e privi di valore.
In questi casi la vergogna diviene un’auto-condanna globale (Tangney, 1991; Niedenthal et al., 1994), finendo per influenzare negativamente gli aspetti del sé fisici e psicologici.
Quando compare la vergogna

A questa età il bambino sa che il suo comportamento può avere delle ripercussioni sugli altri e che in base a questo si possono avere diverse risposte a livello relazionale.
Ecco che per questo farà più attenzione alla sua immagine e a come arriverà agli altri.
Vergogna e senso di colpa
All’emozione della vergogna spesso è associato il senso di colpa; entrambe sono un’emozione sociale e rappresentano una risposta all’aver fatto un torto a qualcuno.
Sebbene vergogna e colpa siano positivamente correlate e spesso usate in modo intercambiabile, l’evidenza empirica suggerisce che sono, in effetti, esperienze emotive diverse che portano a risultati psicologici e comportamentali molto diversi (Tangney, 1991).
Nello specifico la vergogna è considerata in senso lato come un’emozione che coinvolge l’auto-riflessione e la valutazione di sé. (Tangney, 2003)
Si riferisce quindi ad aspetti che reputiamo inaccettabili del nostro carattere o della nostra persona. Si prova quindi quando percepiamo di non essere abbastanza bravi in qualcosa.
Chi la sperimenta di solito cerca di nascondersi e di fuggire.
Nel senso di colpa, invece, il comportamento diventa oggetto di valutazione (Niedenthal et al., 1994): si prova un disgusto morale per i comportamenti negativi e per la violazione delle norme sociali.
La colpa si riferisce, quindi, a qualcosa che sentiamo di aver fatto in modo sbagliato o ad un comportamento per cui ci sentiamo appunto in colpa.
Chi la sperimenta di solito prova a riparare al danno.
Riassumendo, il senso di colpa motiva la persona a riparare il danno mentre la vergogna porta a evitare il danno.
Quando l’emozione diventa disadattiva
La vergogna, se non porta anch’essa ad una riparazione, rischia di diventare fortemente disadattiva in quanto porta a sperimentare un sentimento profondamente negativo verso se stessi, nonché a sentirsi inaccettabili, indegni e manchevoli.
Questo accade quando genera come conseguenza dei comportamenti disfunzionali, come ad esempio l’evitamento.
Prendiamo il caso di una persona che per vergogna evita di presentare il suo libro in pubblico. In tal caso la vergogna è disadattiva. L’esposizione pubblica (cioè la presenza di altri) aumenta anche la probabilità di provare vergogna (Smith et al., 2002).
In tal caso si possono anche sperimentare sentimenti di rabbia e frustrazione per non essere riusciti ad affrontarla. O ancora la persona che vergognandosi di se stessa, si potrebbe autoescludere dalle relazioni sociali.
I segnali dell’imbarazzo
Quali sono i segnali che ci permettono di capire che stiamo provando vergogna?
Lo psichiatra Peter Breggin nel suo libro Guilt, Shame, and Anxiety ne riporta alcuni, vediamoli qui di seguito.
- Sentirsi sensibili;
- Sentirsi non apprezzati;
- Arrossire;
- Sentirsi rifiutati;
- Essere preoccupati di ciò che gli altri pensano;
- Preoccuparsi di non essere trattati con rispetto;
- Sentire come se gli altri se ne approfittassero;
- Voler avere l’ultima parola;
- Evitare di condividere pensieri o sentimenti per paura di sentirsi imbarazzati;
- Aver paura di sembrare inappropriati o stupidi;
- Essere più preoccupati del fallimento che di fare qualcosa di immorale;
- Essere perfezionisti;
- Sentirsi esclusi;
- Sentirsi sospettosi o come se non ci si potesse fidare degli altri;
- Non voler essere al centro dell’attenzione;
- Voler escludere le persone o ritirarsi;
- Cercare di nascondersi o essere poco appariscenti;
- Sentirsi inadeguati;
- Avvertire sentimenti di rimpianto;
- Sentirsi disonorevoli.
Se si parla invece di veri e propri comportamenti che si mettono in atto quando si prova tale emozione abbiamo:
- Guardare in basso invece di guardare le persone negli occhi;
- Tenere la testa bassa;
- Accasciarsi sulle spalle invece di stare dritti;
- Sentirsi congelati o incapaci di muoversi (freezing);
- Non essere in grado di agire in modo spontaneo;
- Balbettare quando si prova a parlare;
- Parlare con una voce troppo dolce;
- Nascondersi dagli altri;
- Piangere se si prova vergogna o imbarazzo.
Le cause della vergogna

Ancora, esser cresciuti in un contesto in cui si è stati valutati in base alla performance o in cui venivano espressi giudizi negativi sulla persona più che sul comportamento.
Più un bambino vive l’umiliazione e il disprezzo, più potrà sentirsi poco degno di amore e maggiore sarà il suo sentimento di vergogna.
Anche i propri problemi di salute possono portare a provare vergogna.
Ma facciamo un elenco delle possibili cause:
- Traumi infantili;
- Qualsiasi disturbo di salute mentale che comporta autocritica o giudizio come l’ansia sociale;
- Non sentirsi all’altezza degli standard eccessivamente elevati che ci si prefigge;
- Sentirsi come se i propri difetti o l’inadeguatezza possano essere rivelati;
- Essere stati vittime di bullismo;
- Aspettative deluse;
- Fallimenti;
- Esperienze di rifiuto da parte degli altri.
L’impatto sulla persona
Che impatto negativo può avere tutto questo?
Tra le conseguenze negative della vergogna disadattiva ritroviamo:
- Sensazione di essere imperfetti o sbagliati;
- Ritiro sociale;
- Dipendenze da sostanze o attività;
- Tendenza a mettersi sulla difensiva;
- Atti di bullismo;
- Ego spropositato per colmare la mancanza di valore;
- Problemi a livello fisico e psicologico;
- Depressione e tristezza;
- Senso di vuoto;
- Bassa autostima;
- Poco fiducia negli altri;
- Perfezionismo;
- Comportamenti compulsivi come dieta rigorosa, pulizia eccessiva o avere standard troppo elevati in generale.
Come affrontare la vergogna
Per affrontare il senso di vergogna, la prima cosa da fare è capire cosa ci vuole dire e come influenza noi e le nostre decisioni.
Prestare attenzione all’emozione e appuntarsi su un diario, nel momento preciso in cui accade, quando si manifesta, con chi, in quali situazioni, quando pensiamo a cosa, come reagiamo, ci aiuterà a circoscrivere il momento e a cominciare ad averne più consapevolezza.
Questo significa esplorare la propria vergogna e capire come influisce sulla propria vita.
Una volta fatto ciò, per ridurre i sentimenti di vergogna è utile provare a trasformarli in sentimenti di colpa, ovvero spostare la responsabilità del danno da se stessi, al comportamento.
Questo porta allo step successivo, che consiste nel cercare di correggere il torto che ha portato a sperimentare l’emozione. Questo potrebbe significare semplicemente scusarsi per una trasgressione, sostituire qualcosa che è stato rotto o riparare in altro modo il danno che si è causato.
Infine praticare l’auto-compassione per migliorare la visione che avete di voi stessi. Provate a scrivere una lettera a voi stessi e immaginate di scriverla dal punto di vista di chi ritenete essere più grande di voi. Magari dal punto di vista di un vostro genitore o di qualcuno che vi ha fatto provare vergogna in passato: il messaggio che scrivete però deve essere gentile e solidale.
Essendo quindi un’emozione universale, non possiamo evitarla e per affrontarla bisogna accettarla, conoscerla e abbracciarla.
Potete provare a farlo da soli o con l’aiuto di un professionista che vi guidi in questo processo di conoscenza di noi stessi.
Per fissare un primo appuntamento puoi scrivermi un'e-mail all'indirizzo davide.algeri@gmail.com
o contattarmi al numero +39 348 53 08 559.
Se ti è piaciuto questo articolo puoi seguirmi sul mio account personale di Instagram, sulla Pagina Ufficiale Facebook di Psicologia Pratica o nel Gruppo di Psicologia Pratica. © Copyright www.davidealgeri.com. Tutti i diritti riservati. È vietata la copia e la pubblicazione, anche parziale, del materiale su altri siti internet e/o su qualunque altro mezzo se non a fronte di esplicita autorizzazione concessa da Davide Algeri e con citazione esplicita della fonte (www.davidealgeri.com). È consentita la riproduzione solo parziale su forum, pagine o blog solo se accompagnata da link all’originale della fonte. È altresì vietato utilizzare i materiali presenti nel sito per scopi commerciali di qualunque tipo. Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive modifiche.
Richiedi un primo contatto



