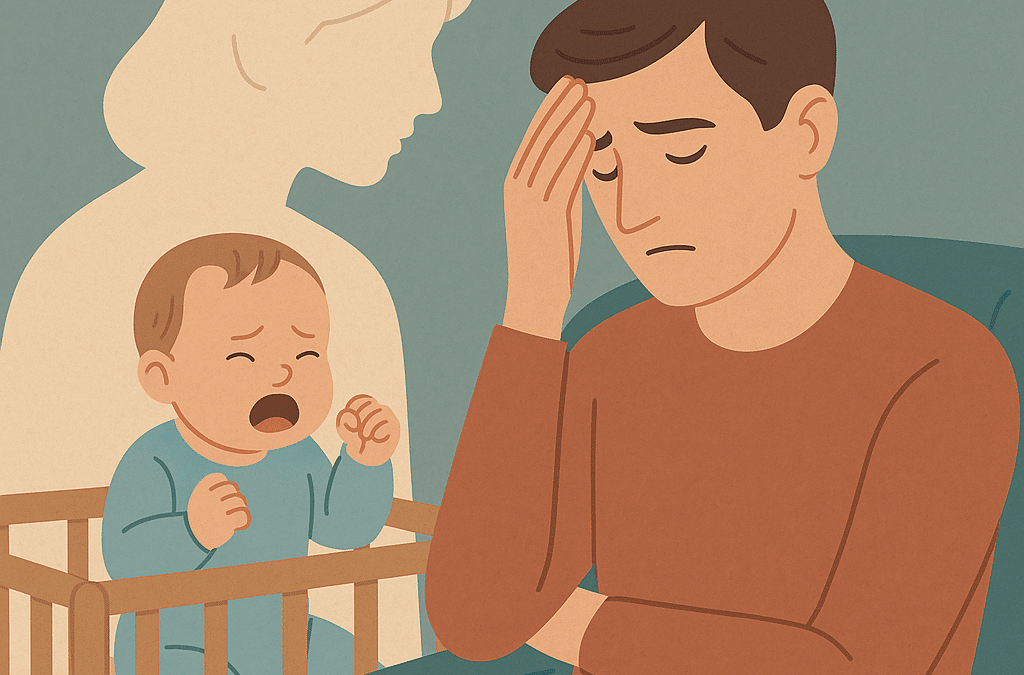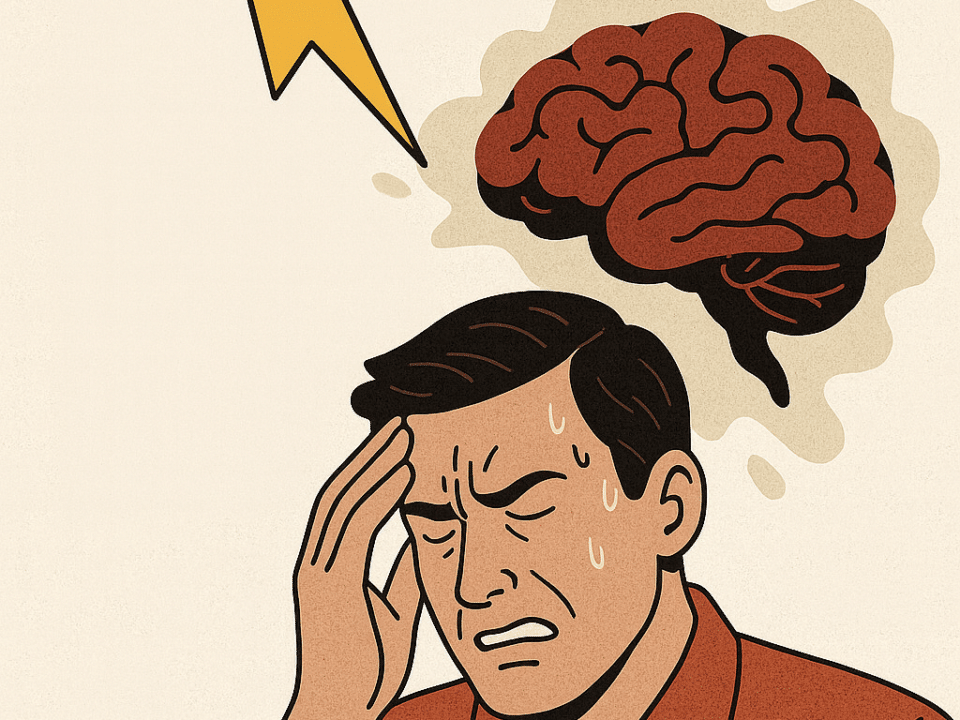Come superare un abuso narcisistico
5 Maggio 2025
Relazioni che cambiano: strategia d’amore nell’epoca dell’individualismo
15 Maggio 2025“Chi si basta da solo non ha bisogno di nessuno, ma spesso è proprio questo il problema.”
Ti sei mai trovatə nella situazione di desiderare l’amore, ma sentire un fastidio inspiegabile quando qualcuno si avvicinava troppo? Oppure di provare disagio nel dover chiedere aiuto, quasi come se fosse un’umiliazione? O ancora, di cercare relazioni affettive ma poi di fuggirne non appena diventavano troppo intime?
Se la risposta è sì, potresti inconsapevolmente agire secondo uno schema di attaccamento evitante.
L’attaccamento evitante è la storia di chi ha imparato a bastarsi per non essere feritə. Ma nel fare di tutto per proteggersi dalla delusione, ha perso anche l’incanto del contatto.
L’attaccamento che si apprende nell’infanzia
La teoria dell’attaccamento, sviluppata dallo psicoanalista John Bowlby nel secolo scorso, è il risultato di anni di osservazione dei comportamenti relazionali nei primi anni di vita, non solo nei bambini ma anche nei mammiferi. Secondo Bowlby, il bisogno di costruire legami è innato quanto quello di nutrirsi: il neonato cerca la prossimità della figura di attaccamento per sentirsi al sicuro nel mondo.
Non si tratta solo di una questione emotiva: un attaccamento sicuro protegge lo sviluppo del cervello, della personalità, del senso di sé. Al contrario, un attaccamento disfunzionale può dare origine a problemi che si manifesteranno in età adulta sotto forma di disturbi d’ansia, sintomi dissociativi, depressione, dipendenze, o tratti di personalità rigidi e autodifensivi.
Le 4 fasi dell’attaccamento (secondo Bowlby)
- Dalla nascita alle 8-12 settimane: il neonato non distingue ancora tra le persone che lo circondano, ma comincia a riconoscere la madre dalla voce e dall’odore. Si attivano i primi segnali della ricerca di contatto.
- Dal secondo al settimo mese: il bambino diventa più selettivo e comincia a discriminare chi lo accudisce. Nasce la preferenza affettiva.
- Dal nono mese: l’attaccamento si consolida. Il bambino cerca attivamente la figura di riferimento, la usa come base sicura da cui esplorare il mondo. Ogni separazione diventa fonte di ansia. L’altro diventa il faro della sicurezza.
- Dai 2 ai 3 anni: il bambino è più autonomo, ma ha bisogno di sapere che la figura di attaccamento è disponibile e che ritornerà. Questo modello mentale resterà inciso nel modo in cui costruirà tutte le relazioni future.
Lə bambinə che in queste fasi non riceve risposte coerenti, affettuose e prevedibili, apprende una lezione velenosa: non posso contare su nessuno, dunque mi salvo da solə.
Quando l’autonomia diventa un bunker: “se mi avvicino, mi perdo”
Nellə bambinə, l’attaccamento evitante nasce da un caregiver emotivamente assente, imprevedibile o respingente. Il messaggio sottinteso che passa è: “I tuoi bisogni non sono legittimi. Cavartela da solo è la tua unica via.”
Così, per sopravvivere, sviluppa una strategia paradossale: reprimere il bisogno stesso di connessione, negare la vulnerabilità e rendersi invisibile nel bisogno.
Nella nostra cultura l’autonomia è celebrata. L’indipendenza, idolatrata. “Non dipendere da nessuno” è l’imperativo sottile che permea le relazioni sociali e professionali. Ma c’è una differenza abissale tra autonomia autentica e autonomia difensiva.
Chi ha sviluppato un attaccamento evitante non è realmente liberə: è strategicamente isolatə.
Il circolo vizioso dell’attaccamento evitante funziona così: più eviti l’intimità per paura di soffrire, più ti senti solo. Più ti senti solo, più credi che l’amore non esista. E più lo credi, più ti convinci che sia meglio fare da sé.
Un gioco di specchi dove ogni passo per “proteggersi” genera proprio ciò da cui si fugge.
Non si tratta quindi di un semplice desiderio di privacy o riservatezza, ma di una costruzione rigida nata da un’esperienza precoce: l’aver imparato, troppo presto, che affidarsi agli altri significa esporsi a delusione, trascuratezza o dolore.
Ma ciò che si nega non scompare: si seppellisce. E ritorna, in forme mascherate, nell’età adulta.
Affettività e lavoro nell’attaccamento evitante
L’adulto con attaccamento evitante non si sente mai davvero al sicuro nelle relazioni, ma non lo mostra. Semplicemente, le evita o le sterilizza. Ha imparato presto che mostrare bisogni o emozioni era inutile, o addirittura pericoloso.
“Chi non si fida, fugge. Ma nella fuga si porta dietro proprio ciò da cui voleva liberarsi.”
Legami affettivi
Chi manifesta un attaccamento evitante tende a:
- prediligere partner distanti, sfuggenti o emotivamente non disponibili,
- fuggire l’intimità quando inizia a sentire coinvolgimento,
- vivere il bisogno dell’altrə come una trappola o una minaccia,
- usare il silenzio, la razionalizzazione e il controllo per non cadere nella dipendenza,
- rifuggire l’intimità, anche quando la desidera,
- sabotare le relazioni quando diventano troppo profonde,
- percepire i bisogni dell’altrə come richieste soffocanti o invadenze.
Come se l’amore fosse un contratto pericoloso, firmato col sangue della propria libertà.
Ne deriva un repertorio affettivo fatto di relazioni “on-off”, incompiute, frustrate o emotivamente aride.
L’amore c’è, ma viene trattenuto. Come acqua dietro una diga: non si lascia fluire per paura dell’inondazione.
Relazioni lavorative
Nel contesto lavorativo, l’autonomia estrema può sembrare inizialmente un punto di forza:
- si mostra autosufficiente, competente, affidabile. Ma non chiede mai supporto,
- si rifiuta di delegare, perché fidarsi dell3 altr3 equivale a esporsi al fallimento,
- evita i feedback, perché li percepisce come minacce alla propria immagine di invulnerabilità,
- si rifugia nell’efficienza per evitare il rischio della cooperazione autentica,
- gestisce in autonoma i progetti,
- prende decisioni senza bisogno di confronto,
- punta a standard elevati,
- si isola professionalmente,
- fatica nel creare team coesi,
- presenta un eccessivo carico mentale.
Il risultato? Una carriera magari brillante, ma spesso vissuta in una prigione di solitudine.
L’autonomia che non si apre alla cooperazione si trasforma in solitudine produttiva: si lavora tanto, ma non si cresce insieme.
Tentate soluzioni che peggiorano il problema
L’adultə con attaccamento evitante mette in atto comportamenti protettivi che inizialmente difendono dagli attacchi del mondo esterno, ma che a lungo andare creano una corazza che isola dall3 altr3, trasformandosi in una trappola.
Ogni tentativo di evitare il dolore della dipendenza diventa, nel tempo, il dolore stesso. Vediamo le principali “strategie fallimentari” che mantengono in vita il problema:
1 – Negare i bisogni emotivi e evitare le richieste
La persona ha paura di chiedere aiuto perché teme che sia umiliante e razionalizza tutto, anestetizzando il cuore. La frase che spesso passa per la mente di chi adotta un comportamento evitante è: “Non ho bisogno di nessuno.”. Dentro di sé sa che è una bugia, ma sente di non poter fare altrimenti. Il bisogno represso così ritorna, sotto forma di insoddisfazione, cinismo o disturbi psicosomatici.
2 – Svalutare il legame o evitare l’intimità
Chi adotta un comportamento evitante sminuisce l’importanza delle relazioni (“le persone sono tutte egoiste”) andando così a giustificare l’autoesclusione. Anche in questo caso, un’arma a doppio taglio che protegge, ma al tempo stesso isola. In altri casi, quando il legame si fa più intenso, tende a fuggire.
3 – Attivare il controllo ossessivo
Chi non si fida, controlla. Chi non si affida, domina. Spesso l’attaccamento evitante genera stili relazionali freddi, distaccati o iper-razionali.
4 – Investire tutto sul “fare”
La persona evitante è un’instancabile lavoratrice, sportiva, performer. Il fare riempie il vuoto dell’essere. Ma il fare compulsivo non sostituisce mai il nutrimento emotivo.
5 – Evitare il conflitto
L’evitante preferisce andarsene in silenzio piuttosto che rischiare un confronto. Ogni evitamento protegge nell’immediato, ma rischia di costruire un deserto emotivo nel tempo.
I sintomi di una vita evitante
- Difficoltà a lasciarsi andare nelle relazioni.
- Paura dell’intimità o del bisogno reciproco.
- Malessere quando si dipende da qualcuno.
- Tendenza all’ipercontrollo o al perfezionismo.
- Sensazione costante di dover fare tutto da sol3.
- Difficoltà a chiedere aiuto anche nei momenti critici.
- Difficoltà a costruire legami duraturi.
- Difficoltà ad esprimere vulnerabilità.
- Sensazione di “freddezza emotiva”.
- Rabbia trattenuta, trasformata in chiusura.
- Relazioni intense ma brevi, o lunghe ma vuote.
- Ansia mascherata da ipercontrollo.
Il problema non è non avere bisogno dell’altro. Il problema è averlo, e vergognarsene.
E il più grande paradosso: si desidera amore, ma si fuggono tutte le sue forme autentiche.
Come rompere il copione
Superare l’attaccamento evitante non significa trasformarsi in una persona dipendente, ma riabilitare il bisogno di connessione come parte legittima della propria umanità. Significa scegliere la connessione, anziché evitarla per paura.
Ecco 3 suggerimenti concreti da applicare fin da subito:
1 – Pratica l’imperfezione relazionale
La prima cosa da fare è quella di cominciare ad immunizzarsi all’imperfezione e al piccolo aiuto, non per bisogno, ma per disinnescare la rigidità, non perché bisogna aggrapparsi all’altro, ma perché bisogna imparare a costruire un’alternativa da poter scegliere, in caso di bisogno. Chiedi quindi deliberatamente aiuto su qualcosa di semplice ma personale, una volta al giorno per 7 giorni.
Non per necessità, ma per disintossicarsi dal mito della perfezione. Non per ottenere qualcosa, ma per esperire la possibilità di affidarsi.
“Solo chi si affida può scoprire che non era debole, ma umano.”
2 – Tieni un diario delle micro-aperture programmate
Impara ad aprire pian piano il tuo mondo esterno alle persone di cui ti fidi. Allena l’intimità con piccoli gesti. Ogni sera, annota 3 episodi (anche minimi) in cui sei statə capace di condividere un’emozione, di dire una frase personale in più, un messaggio sincero, un invito spontaneo, di accettare una proposta non pianificata o un aiuto. Al contempo, osserva come reagisce l’altrə (e tu stessə).
Questo esercizio sviluppa la consapevolezza progressiva che aprirsi non equivale a perdersi, e che il rischio dell’intimità è il prezzo della pienezza.
3 – Immagina di essere un’isola col ponte
Immagina di essere un’isola sicura con un ponte levatoio che puoi decidere tu quando alzare e abbassare. Ogni giorno apri quel ponte a qualcuno, anche solo per un gesto: una chiamata, una confidenza, un invito.
L’obiettivo è riconquistare la flessibilità: essere capaci di stare da soli, ma anche di accogliere senza perdere sé stessi.
“Aprirsi non significa essere invasi, ma permettere a chi merita di entrare.”
L’intimità come scelta, non come minaccia
L’attaccamento evitante è un modo di evitare il dolore. Ma nel tentativo di non soffrire, si finisce per non vivere.
Romperne la logica significa riprogrammare l’idea che affidarsi sia un rischio mortale. In realtà, è il contrario: è proprio la solitudine assoluta a uccidere lentamente la nostra umanità.
Essere autosufficienti è un valore. Essere impermeabili, un inganno.
Riconoscere lo schema non è indebolirsi. È il primo passo per scegliere relazioni nutrienti, non come minaccia, ma come espansione.
Se vuoi iniziare a cambiare non servono rivoluzioni emotive, ma un piccolo atto di fiducia, ogni giorno.
Perché solo osando ciò che temiamo, possiamo guarire ciò che ci blocca.
Per fissare un primo appuntamento puoi scrivermi un'e-mail all'indirizzo davide.algeri@gmail.com
o contattarmi al numero +39 348 53 08 559.
Se ti è piaciuto questo articolo puoi seguirmi sul mio account personale di Instagram, sulla Pagina Ufficiale Facebook di Psicologia Pratica o nel Gruppo di Psicologia Pratica. © Copyright www.davidealgeri.com. Tutti i diritti riservati. È vietata la copia e la pubblicazione, anche parziale, del materiale su altri siti internet e/o su qualunque altro mezzo se non a fronte di esplicita autorizzazione concessa da Davide Algeri e con citazione esplicita della fonte (www.davidealgeri.com). È consentita la riproduzione solo parziale su forum, pagine o blog solo se accompagnata da link all’originale della fonte. È altresì vietato utilizzare i materiali presenti nel sito per scopi commerciali di qualunque tipo. Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive modifiche.
Richiedi un primo contatto