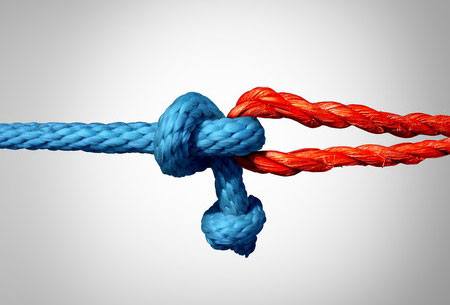
Caratteristiche del legame di attaccamento
25 Novembre 2011
Psicologia online e di consulenza a distanza: i servizi del S.I.P.O.
2 Dicembre 2011
La durata della seduta è in genere di circa 15-20 minuti mentre nel caso in cui l’operatore si trovi a gestire una seduta di gruppo, solitamente composto da 5-7 pazienti, la durata della seduta raddoppia (Vigorelli P., 2004).
È noto dagli studi condotti dall’Infant Research (Beebe B., Lachmann F.M., 2002) quanto nelle prime fasi di vita del bambino la relazione interattiva con la madre si fondi sul linguaggio paraverbale: gesti, intonazioni, ritmi di voce servono affinchè si crei quella che Stern definisce “sintonizzazione affettiva” (Stern D., 1987), la quale crea il terreno fertile per il consolidamento del mondo interno del piccolo. Facendo riferimento al concetto di retrogenesi secondo il quale “la progressione delle perdite funzionali e quindi della sintomatologia, nell’invecchiamento in generale e nell’AD in particolare, segue un ordine che è inverso rispetto a quello delle acquisizioni funzionali nello sviluppo umano normale considerate secondo una prospettiva piagetiana.” (Bolis S., in Vigorelli P., 2004), come nei primi mesi di vita è necessario curare e prestare particolare attenzione al linguaggio paraverbale, allo stesso modo, nel momento in cui un operatore (o il familiare a casa) si appresta a dare avvio ad una conversazione secondo i principi del conversazionalismo con una persona malata d’Alzheimer, è fondamentale: affiancare le parole ai gesti; utilizzare un tono di voce che infonda tranquillità; parlare chiaramente e con frasi piuttosto brevi; esplicitare un concetto alla volta; avvalersi di pause e rispettare il silenzio attendendo la risposta (Vigorelli P., 2008). Affinchè il paziente e colui che propone la conversazione possano godere entrambi dei benefici derivanti dall’uso del conversazionalismo, è importante, inoltre, che quest’ultimo sia in grado di mettere da parte alcuni comportamenti che normalmente vengono messi in atto nel momento in cui ci si relaziona con una persona con Alzheimer, tra questi è possibile individuare: porre domande ed in successione, incalzando il paziente: si è visto, infatti, dall’analisi di numerose conversazioni con malati Alzheimer che “spesso chi parla fa delle domande al malato, quasi per metterlo alla prova, per verificare se riesce ancora a rispondere, se riesce a ricordare quello che gli è appena stato detto, se riesce ad orientarsi nel tempo(…) il malato impiega molto tempo ad elaborare la domanda e nel momento in cui viene incalzato con una nuovo quesito, si finisce con indurre nel paziente una sensazione di spaesamento, confusione, rabbia, portandolo a non rispondere”; viene suggerito pertanto l’uso di frasi dichiarative (Vigorelli P., 2008).
Ancora il malato di Alzheimer parla lentamente e presenta un’inerzia verbale in particolar modo all’inizio della conversazione, pertanto, fa fatica a cominciare a parlare. Da qui l’importanza di saper aspettare e rispettare i tempi del soggetto, dunque, di desistere dalla tendenza, nel momento in cui il soggetto prenda la parola, ad interrompere, a sovrapporsi al suo discorso o a completare le frasi ma soprattutto di saper tollerare il silenzio. Il silenzio è spesso fonte di frustrazione sia per il familiare che per l’operatore alle prime armi ed è spesso ciò che sollecita a commettere degli errori. Nel corso di una seduta conversazionale con un paziente affetto da AD il silenzio può prendere parte della seduta ma l’approccio conversazionale getta una nuova luce sul significato del silenzio: esso, infatti, viene visto come il punto di partenza dal quale possono emergere emozioni, comportamenti non verbali. “Nel silenzio il paziente ritrova uno stato di libertà in cui può parlare o può tacere, senza timore di essere inadeguato o di essere giudicato. Ma soprattutto il silenzio è quello spazio da cui scaturiscono le parole, è quello spazio in cui si costruisce un mondo possibile che noi possiamo accettare e condividere.” (Vigorelli P., 2004).
Il conversazionalismo invita anche l’operatore o il familiare ad assumere un atteggiamento empatico al fine di potersi mettere nei panni del malato: in questo modo superando il concetto di monoidentità citato precedentemente sarà possibile dare spazio ai mondi possibili del paziente e riscoprire una vita, un mondo interiore del soggetto ancora ricco e popolato di emozioni, ricordi, personaggi. Diverse sono le tecniche suggerite da Vigorelli per riuscire a mantenere il contatto conversazionale con il paziente, tra queste le più importanti sono: fare eco alle parole del paziente cioè rispondere ripetendo le ultime parole pronunciate dal malato o, ancora, restituire il tema del discorso, tecnica, quest’ultima, che consiste nel ripetere con parole chiare e semplici ciò che il paziente ha raccontato. A tale modalità è possibile, per il conversante affiancare ed inserire frammenti della propria autobiografia purchè questi non si allontanino eccessivamente dal tema più importante. L’ opportunità che il conversazionalismo fornisce al familiare, all’operatore, di raccontare di parti di sé, durante il dialogo con il malato, consente di riequilibrare e rendere la conversazione il più normale possibile evitando, quindi, concentrando l’attenzione esclusivamente sul paziente, di eclissare una della due personalità entrate in gioco nella relazione e nel dialogo, quella del curante. “Nelle conversazioni di vita quotidiana ci sono due persone adulte, di cui una è malata, ma entrambe hanno una loro storia, un loro carattere, un loro modo di stare al mondo e di comprenderlo, una relazione che si è costruita anno dopo anno. Ciascuno porta dentro di sé le tracce di una lunga vita. Per avere una conversazione felice è bene che di tanto in tanto anche il familiare si metta in gioco in prima persona, che racconti qualcosa di sé, di quello che pensa, di quello che ricorda.” (Vigorelli P., 2008). In tal modo viene ripristinato un rapporto simmetrico e paritario e si restituisce dignità tanto al malato quanto al familiare. Ciò che emerge analizzando le tecniche di cui si avvale la terapia del conversazionalismo è che l’operatore che si appresta ad entrare in contatto con il paziente rinuncia all’utilizzo del cosiddetto paradigma indiziario di cui si avvale la psicologia e più nello specifico la psicoterapia: cercare di percorrere insieme al paziente una strada che consenta sulla base di elementi, indizi forniti dal paziente stesso di scoprire la verità, di accedere ad un livello di comprensione sino ad allora ignoto al soggetto (Del Corno F., Lang M., 2005).
Si rinuncia pertanto all’interpretazione a favore della restituzione la quale consente di entrare in relazione anche con pazienti eccessivamente deteriorati. Partendo dal presupposto che l’obiettivo della terapia conversazionale, come per ogni tipologia di intervento riabilitativa rivolta al paziente affetto da AD, non consiste nella guarigione della malattia, i risultati da essa ottenuti vengono considerati da Vigorelli di tipo “aggiuntivo” i quali comportano cambiamenti positivi nella qualità della vita del paziente e dei familiari (Vigorelli P., 2005). Diversi studi condotti inoltre sulla base dei testi delle sedute registrate e trascritte testimoniano che la modalità di esprimersi dei pazienti, normalmente connotata da numerose frasi interrotte, nel corso delle sedute di terapia conversazionale, mostra una buona coerenza, coesione e fluidità, nonché un miglioramento tra i nessi prettamente formali tra le varie parole e, infine, aspetto che emerge in particolar modo nelle sedute di gruppo, è il rispetto dei turni verbali. Tutto ciò va a confermare quanto sostenuto da Lai rispetto al permanere della capacità conversazionale nel soggetto affetto da Alzheimer (Lai G., 2000b).
Bibliografia
- Beebe B., Lachmann F.M., Infant research e trattamento degli adulti. Un modello sistemico-diadico delle relazioni, Raffaello Cortina, Milano, 2002.
- Del Corno F., Lang M., Elementi di psicologia clinica, Franco Angeli, Milano, 2005.
- Vigorelli P., La conversazione possibile con il malato, Franco Angeli, Milano, 2004.
- Vigorelli P., “Comunicare con il demente: dalla comunicazione inefficace alla conversazione felice”, in Giornale Gerontologia, n° 53, 2005.
- Vigorelli P., Alzheimer senza paura, manuale di aiuto per i familiari, perché parlare, come parlare, Rizzoli, Milano, 2008.
Per fissare un primo appuntamento puoi scrivermi un'e-mail all'indirizzo davide.algeri@gmail.com o contattarmi al numero +39 348 53 08 559.
Se ti è piaciuto questo articolo puoi seguirmi sul mio account personale di Instagram, sulla Pagina Ufficiale Facebook di Psicologia Pratica o nel Gruppo di Psicologia Pratica. © Copyright www.davidealgeri.com. Tutti i diritti riservati. E’ vietata la copia e la pubblicazione, anche parziale, del materiale su altri siti internet e/o su qualunque altro mezzo se non a fronte di esplicita autorizzazione concessa da Davide Algeri e con citazione esplicita della fonte (www.davidealgeri.com). E’ consentita la riproduzione solo parziale su forum, pagine o blog solo se accompagnata da link all’originale della fonte. E’ altresì vietato utilizzare i materiali presenti nel sito per scopi commerciali di qualunque tipo. Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive modifiche.



